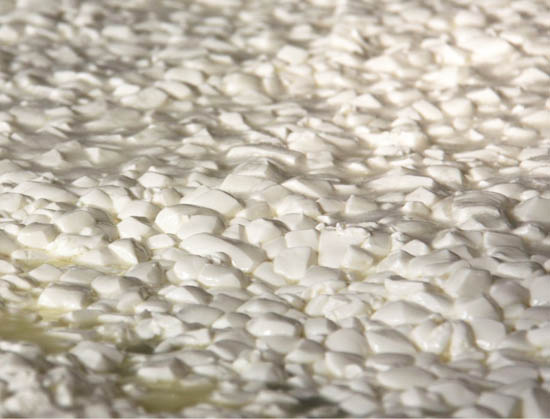Valle Spluga. Valcava. Quella distanza da Chiavenna e da Madesimo rassicurante e selvaggia. Fuori stagione qui mancano anche le eventualità del raggiungimento. La Svizzera è determinante, non ci sono valichi e non ci sono più opportunità di scelta. La cultura alpina si è fatta in altri versanti dove la dimenticanza è diventata recupero e opportunità di lustrino. Qui l’abbandono è ancora oggi un tempo senza soluzione. La patata, che nel corso dei secoli ha sostituito le radici nell’alimentazione montana, dalla metà dell’ottocento è diventata sussistenza e salvezza, omologazione e impossibilità di farne a meno. Quando alla povertà si è sostituito il turismo e anche il curato ha preferito dei nitidi box alla coltivazione della patata di Starleggia, ormai rimasta avamposto leggendario e introvabile, eccezion fatta per qualche privato e per due chiavennaschi che han pensato bene di ridar vita a degli orti in quota e al Giardino Alpino Valcava, l’espressione si è trasformata in un risarcimento più che in un recupero. Saul Caligari, ex giardiniere e appassionato botanico, e Antonio Scaramellini, ex architetto sono alle radici di quel resta… Continue reading Patata di Starleggia: un recupero anticonvenzionale… Saul Caligari e Antonio Scaramellini
Categoria: Artigiani del gusto
Carne d’alpeggio e salumi apotropaici… Ivano e Claudio Pigazzi
Pasturo. Fuori stagione. Buio profondo, leggere salite e persone raffreddate che si contano sulle dita di una mano. La Valsassina, nella sua decadenza di valle compresa ma senza sbocchi, ha un turismo poetico di recupero baite che con la contemporaneità non ha nulla da spartire. Qui la possibilità di bellezza empatica se la sono giocata, hanno abbandonato gli artigiani a loro stessi e si son messi in marcia verso più sicure produzioni. Qui si confezionano industrialmente tonnellate di taleggi in cui nessuno, almeno in valle, sembra volersi riconoscere. Trarsi fuori dal fenomeno è compito imprudente. Soprattutto in anni di vacche magre e di conflitti tra burocrazia e “burocratati”. In questo paese agiato a valle, assopito di fronte a preoccupazioni e vendite, l’azienda agricola e la macelleria della famiglia Pigazzi è quella mosca bianca contraltare di bevute pomeridiane, chiacchiere da bar e gioventù bruciate prima di partire… Continue reading Carne d’alpeggio e salumi apotropaici… Ivano e Claudio Pigazzi
Gli alpeggiatori d’inverno… Roberto Paggi
Prata Camportaccio, frazione di San Cassiano. Statale 36 dello Spluga. Uno di quei paesi che si tralasciano per arrivare ad un confortante bombardino, assisi al sole di valli che non hanno più niente da ridare indietro se non conformismo. I ganassa metropolitani si son presi tutto, lasciando qualche briciola sparsa e qualche traccia in luoghi manifesti e infestati da accenti locali, fiumi gelati e e un apporto alla montagna necessario e quotidiano. Qui, riuscendo ancora ad inclinare lo sguardo per trovare una giornata di sole invernale che riverberi lo stupore, la vista rimane intatta su un trivio di valli assolutamente licenzioso. Queste sono territori di miseria e nobiltà sperata, l’affaccio turistico è arrivato nel tempo, quando l’immigrazione era già partita ed era già tornata. La poca terra era luogo di pura sopravvivenza, di cereali scomparsi e di lunghe gelate invernali, qui si guardava alla fuga come ad uno dei pochi benesseri. Rendere operai i contadini non è mai stata un’operazione di sollievo e così, chi ha potuto, è tornato alla terra e a quella genealogia che non si può mai nascondere. Continue reading Gli alpeggiatori d’inverno… Roberto Paggi
Un sorprendente pasticciere nascosto … Francesco Elmi
Bologna, mentre il sole decade e si colora ruggine, è di una bellezza sdilinquente. Pingue come solo i ducati sanno essere, senza nemmeno più bisogno della collina e dei retaggi gastronomici. Il mio ricordo della città, nebbioso, vorticoso e assolutamente gelido, è rimasto impacciato e si è messo in discussione attraverso il paesaggio: attraverso via Drapperia, immagine ghiotta e focolare di una Vucciria palermitana quantomai spietata, via Castiglione, le sue diramazioni e i suoi mendicanti invecchiati insieme alle strade e tagliati dal freddo come non fossero mai usciti dall’incubo della necessità, piazza Maggiore, con quelle facciate che non lasciano nulla all’immaginazione e quel passeggio che non ha una direzione se non quella dell’esserci lì ed ora, via Galliera, cupa, sepolta con i portici a volte schiaccianti e sali e scendi tra mercati e piazzette. Bologna ha una borghesia laterale che costruisce case con giardini per proteggere la propria ipocrisia e il ritorno dei figli disillusi e sudici di vita, e una miscellanea d’inaspettato che la pervade a folate, come se non ci fosse altro da fare che infondere splendore e sovrabbondanza in luoghi partecipati, noiosi, adatti, politici ed economicamente legati al disinteresse. Bologna è una chiacchiera continua di voci senza direzione. E così, prima di perdermi anche io, prendo la decisione di camminarla obliquamente con la pancia satolla e il palato stupefatto. Tutto ciò grazie o a causa di Francesco Elmi e della sua Regina di Quadri. Continue reading Un sorprendente pasticciere nascosto … Francesco Elmi
Valsamoggia: una storia d’imprenditoria e formaggi… Gabriele Manzini
Quello che fu Monteveglio e che è Valsamoggia, la fusione di luoghi distanti, di territorialità dissepolte e di hinterland che diventano colline e montagne. L’agricolo non è stato soppiantato del tutto dall’urbanizzato e il paesaggio, abbandonato al selvatico, rimane possedimento di quei colli che, al di là dei vigneti, mostrano ancora cieli tersi e obliqui impossibili da non fotografare. C’è una ripetizione continua di dialettica fascinosa, l’agriturismo, l’agriturismo da tortellino in brodo ed eretica rivisitazione con la panna, saliscendi continui, curve a gomito, orizzonte sconfinato e un tempo della sosta che non è mai noia. Così spariscono le fabbriche e appaiono le scenografiche costruzioni in pietra abbandonata, un segno umile che la collina si è presa al di là delle rotonde e delle linee dritte. La Valle del Samoggia è un fluire di calanchi e tradizioni, una comunione d’intenti prima che unione d’interessi, dove i mulini sono ancora mulini e le pievi possono esprimere ancora la funzione rurale di aggregazione e di campagna. Qui, pochi metri dopo il mercato e pochi metri prima dell’oblio, la famiglia Manzini ha deciso di rielaborare il proprio punto di vista su commercio, artigianato e tradizione. Continue reading Valsamoggia: una storia d’imprenditoria e formaggi… Gabriele Manzini
Nocciole su terreni vocati e solo queste storie… Emanuele Canaparo
Cravanzana. Mille alberi di noccioli per abitante. Un luogo dove i profumi sono talmente nitidi da non aver bisogno di nessuna spiegazione, una rappresentazione icastica dell’Alta Langa senza necessità di racconti o fotografie. Qui, le curve del vino lasciano spazio a quelle delle nocciole, all’abbandono, all’inselvatichirsi e a quelle colline che sono rimaste al tempo delle colline con solo qualche interesse in più. Sono paesaggi privati e vietati, boschi messi in fila e da tenere a distanza. È meglio non farsi ingolosire, è meglio rimanere spettatore e assaggiatore, chiedere e non imporsi. Le nocciole sono l’esistenza senza foglia di un manipolo di agricoltori, di qualche trasformatore e di Emanuele Canaparo, il primo artigiano trasformatore del proprio prodotto. Continue reading Nocciole su terreni vocati e solo queste storie… Emanuele Canaparo
Rarissimo torrone di filiera… Carlo Minetto
Pezzolo Valle Uzzone, alle porte di Cortemilia. Paesi in decadenza, abbandono e selvatico come forme più che umorali di zone ormai vinte. Qui l’inquinamento si è portato via i vigneti, la crisi le aziende, e il tempo ha lasciato noccioleti, famiglie in disarmo e un florilegio di negozi vuoti. Questa Langa povera ha un mistero senza luogo, di un’avvenenza decadente, che non lascia per strada ville o possibilità di speculazione. Qui, in mezzo a questi boschi di funghi, tartufi e noccioli, dove il dissepolto è una forma urbana di umanità, fare l’artigiano è una missione senza agio. Pena la sparizione. Qui, o fai bene, o non sei. E così chi resiste, chi si protrae nel tempo, procrastinando negli anni la propria fine, è costretto a lavorare bene il territorio, senza frodi e senza assoluzioni. La nocciola, al di là di sgusciatori, approfittatori, venditori di torte alla margarina e industrie dissolute, è una religione che non concede nessuna distrazione. Si scruta il cielo, si spera, si guardano le piante crescere e si subiscono le ondulazioni del famigerato mercato globale. Una nevicata in Turchia cambia tutto. E così lavorarsi il proprio frutto è qualcosa di privato, intimo e assolutamente colloquiale. Continue reading Rarissimo torrone di filiera… Carlo Minetto
Un pane popolare che mette in coda le persone… Alessandro Spoto
Torino. Borgo Vittoria. Dove il popolare diventa dimenticanza del passato. Una polveriera sociale con un’arteria con un unico senso. Un luogo feroce e beato, in mezzo a quella Torino rimasta a nord, con il sud richiamato al di là del Mediterraneo. Un posto vivo, pieno di gente, con la vitalità operaia trasformata in parassitismo e nefandezza. Adesso che sarebbe trendy essere popolari, ci si è dimenticati dell’origine. Così arrivano un po’ di trascuratezza e un po’ di ingorgo, in quella tessitura che è rimasta anima e interesse. Qui il mercato c’è ogni giorno, le chiese sono roccaforti e l’abuso edilizio è stato fermato dalla densità. Ma la periferia delle piole, delle partite a carte e delle discussioni infinite non è morta e non ha rinnegato se stessa. E così qualche artigiano ha deciso di trasformare il proletariato in possibilità, provando a rendere avvincente la storia di un quartiere che non ha mai dormito e si è sempre evoluto. Politicamente, economicamente e culturalmente. Qui, Alessandro Spoto, ha deciso qualche anno fa di avviare la sua attività. Continue reading Un pane popolare che mette in coda le persone… Alessandro Spoto